 U sckazzamurille
U sckazzamurille vive nelle case più vecchie e ha la sua dimora negli interstizi delle pareti.
Ha l'aspetto di un bambino vestito di una tonaca e un cappuccio; anzi, secondo alcuni
è un bambino, non nato o nato morto o morto prima del battesimo. Se lo si sente piangere, bisogna lasciargli una tazza di latte.
Può affezionarsi e far trovare in giro monete, piccoli regali, ma può anche indispettirsi, e in quel caso nasconde gli oggetti o viene a tirarti i piedi mentre dormi.
Camminando per i vicoli, subito dopo la vendemmia, mi abbassavo fino a terra e mi accostavo alle grate coperte di polvere e ruggine, per respirare l'odore violento del mosto in fermentazione che arrivava a zaffate dalle cantine.
Le Madonne erano sette sorelle (l'Annunziata, l'Addolorata, quella del Carmine, quella del Rosario, quella del Soccorso, e le altre due non le ricordo); una volta c'era il sole, sei rimasero a dormire e la sesta uscì a stendere i panni e si abbronzò, ed è per questo che la Madonna del Soccorso ha il volto nero.
La chiesa era enorme, dai finestroni altissimi pioveva una luce grigia. Il sabato pomeriggio si stava tutti insieme su una panca in fondo (d'inverno, il più vicino possibile all'unica stufa, un vecchio radiatore simile a un enorme abat-jour), si leggeva l'elenco dei peccati stampato su un opuscolo e poi, uno per volta, si andava sulla panca in prima fila, dove sedeva il vecchio prete collerico, con le mani annodate dall'artrosi, che ad ogni peccato ti rimproverava urlando a squarciagola.
Quando si fa un complimento a qualcuno, specialmente a un bimbo, bisogna invocare San Martino (
Sande Martine, quand'è belle stu criature). Se non lo si fa, e se nello sguardo c'è invidia, si può lanciare al bambino l'
affascìne (il
fascinum).
Il bambino diventa apatico, svogliato, la testa si fa pesante e ciondola sul petto. Allora bisogna prendere un piatto, riempirlo d'acqua e versarci dentro una goccia d'olio, e osservare se rimane compatta o se si spande. Nel caso, bisogna recitare una giaculatoria ai santi chiedendo di togliere l'
affascìne.
I lunghi giri per evitare il vicolo dove abitava il bulletto riccio dal sorriso protervo, o il magazzino buio e puzzolente, in fondo al quale viveva un cane enorme, sempre alla catena, che si avventava abbaiando sui passanti.
Zecurille viene a prendere i bambini cattivi e li porta via con il suo piede caprino. Anche
u popònne li porta via, ma lui non sono mai riuscito a figurarmelo, è sempre restato una macchia indistinta, come un'ombra più scura in mezzo all'ombra.
La sera del Venerdì Santo la Madonna Addolorata, alla luce del plenilunio, va in giro a cercare il corpo di Gesù, con il pugnale piantato nel petto e un manto isiaco trapunto di stelle. Quella sera si fa il giro delle chiese (tre? cinque? sette?, purché siano dispari) dove è esposto il Cristo morto, con il sangue di cera che cade in goccioline sottili dalle ferite, e tutto intorno piantine di grano cresciute al buio, pallide e trasparenti come gelatina.
Per le vie del centro passa la processione: davanti il Cristo morto in una bara di cristallo, poi la Madonna in lacrime, poi la banda che suona musiche tristissime (il clarinettista aveva una molletta sullo strumento, alla quale attaccava gli spartiti), poi le
bizzoche che cantano
O chiodi crudeli che al mio Redentore / le carni straziate con tanto dolore / non date più pene / al caro mio bene / non più tormentate il caro Gesù, poi i bambini con la tunica rossa la corona di spine e la piccola croce in spalla, poi le bambine vestite come la Madonna.
Molte vie del centro sono ancora pavimentate con lastroni di pietra vulcanica, bianchi o azzurrini, butterati da colpi di scalpello, che con la pioggia diventano scivolosi come ghiaccio.
Mio nonno, che faceva il ferroviere, raccontava che una notte, tornando a casa dopo il turno, un enorme cane nero con gli occhi luccicanti l'aveva seguito per tutta la strada dalla stazione fino a casa. Era l'anima di un morto.
A casa sua ci si riscaldava con i bracieri, le forchette erano di stagno, leggere e tutte corrose, i bicchieri opachi e sapevano sempre di vino, la carta da parati piena di toppe attaccate con farina e acqua. In cima allo sgabuzzino stavano a seccare le mele cotogne.
Nella sua favola preferita, la volpe ingannava il lupo spalmandosi la testa di ricotta e sugo di pomodoro ("guarda, il pastore mi ha rotto la testa a bastonate, il cervello mi esce fuori"), e alla fine era il lupo a morire al posto suo.
L'esercito imperiale di Carlo V assediava San Severo, fedele ai Francesi. La notte in cui la città sarebbe dovuta esser presa a tradimento, un uomo percorse le vie del centro urlando:
Scetàteve, jallinacce, ca mo ce 'mbicce l'acce. I soldati videro un cavaliere che galoppava nel cielo e fuggirono terrorizzati. La mattina dopo, nella chiesa di San Severino, proprio sotto l'altare, si trovarono le tracce degli zoccoli di un cavallo.
La notte del due novembre i morti scendono giù per il camino e portano regali ai bambini, ma la sera prima si deve lasciar loro qualcosa da mangiare.
Gli uomini che portavano le statue dei santi avevano un lungo bastone che terminava con una forcella. Durante le soste, si toglievano l'asta dalla spalla e la appoggiavano sulla forcella.
Sotto il convento dei Celestini c'è una cripta, dove ci sono tante sedie di pietra con un buco in mezzo alla seduta. I monaci morti venivano messi lì, a scolare i liquami della putrefazione. Poi si raccoglievano le ossa e si buttavano giù per il buco, nell'ossario, e si metteva un morto nuovo al posto del vecchio.
Sand'Andune chèpe ricce,
pigghje u foche e jànnelu ppicce,
jànnelu ppicce bbellu bbelle,
Sand'Andune c'u cambanelle.



























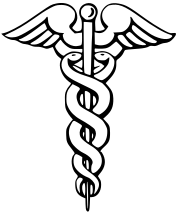





















.png)





