
Powerhouse, Valentine, Scoot e Little Brother escono nella pioggia battente.
“Beh, stanno vuotando i bidoni”, dice Powerhouse con voce addolcita. Per strada tiene le mani in fuori e rovescia i palmi bianchi, come fossero colini.
Un centinaio di neri scuri, stracciati, silenziosi e deliziati sono venuti loro intorno da sotto la tettoia della sala da ballo, li seguono dovunque vadano.
“Badate che Little Brother non si restringa”, dice Powerhouse. “Già adesso sei grande appena quanto basta per non farti risucchiare dal clarinetto. Ti si è seccata la gola, Little Brother, là nel deserto?”. Infila le mani in tasca e e tira fuori una busta di mentine. “Ora tienile in bocca: non masticarle. Non mi porto in giro la roba in quantità illimitata”.
“Andiamo in quel locale a farci una birra”, dice Scott, che cammina avanti agli altri.
“Birra? Birra? Tu lo sai che cos'è la birra? Che cosa dicono che sia la birra? Che cos'è la birra? Da dove vengo?”.
“Laggiù, dove dice World Café: va bene?”. Ora sono a Negrotown.
Valentine sgattaiola avanti e tiene aperta una porta a schermo incavata come una conchiglia, brutto spettacolo con questo tempaccio, ed entrano, anneriti dalla pioggia, lasciandosi dietro impronte sul pavimento. Dentro, odori asciutti e riparati fanno schermo intorno a una tavola coperta da una tovaglia a scacchi rossi, al centro della quale le mosche si aggrappano a una bottiglia di ketchup a forma di obelisco. I muri di mezzanotte sono anch'essi a scacchi, coperti da cartelli ammonitori che dicono “Decliniamo ogni responsabilità”, e da calendari affumicati pieni di figure nere. C'è un juke-box dall'aria disastrata e proprio lì accanto, sul muro, un apparecchio dal lungo collo etichettato come “Telefono d'ufficio, smettere di parlare”. Sopra, da ogni parte, ci sono numeri di telefono cerchiati. C'è una piuma di pavone sgualcita, che penzola legata con un filo a una vecchia, esile, rosata lampadina scoperta, e che gira lentamente su se stessa, al minimo respiro.
Una cameriera osserva.
“Vieni qui, statua vivente, e prendi tutte le grosse ordinazioni di birra che stiamo per fare”.
“Non vi ho mai visto prima, da nessuna parte”. La cameriera si muove e viene avanti, e lentamente mostra foglioline e tralci dorati sui denti. Tira su le spalle e il seno. “Come faccio a sapere chi siete? Rapinatori? Venite fuori dal nero della notte, proprio a mezzanotte, e vi sedete grandi e grossi al mio tavolo”.
“Siamo babau”, dice Powerhouse, con gli occhi che si aprono pigramente come in una grotta.
La ragazza strilla delicatamente di piacere. Santo Cielo, come le piace farsi spaventare da questi discorsi.
“Dove la trovi abbastanza birra da riempirci il tavolo?”.
Corre in cucina, gambe in spalla, a passi felpati.
“Eccovi un milione in spiccioli”, dice Powerhouse, tirando fuori le mani dalle tasche e spargendo monetine tutto intorno, tutte tranne l'ultima, che fa svanire come un mago.
Valentine e Scoot portano i soldi al juke-box, dall'aspetto malandato come una slot-machine, e leggono tutti i nomi dei dischi ad alta voce.
“ 'Tuxedo Junction' di chi?”, chiede Powerhouse.
“Lo sai di chi”.
“Juke-box, ti chiedo per cortesia di suonare 'Empty Bed Blues' e di lasciar cantare Bessie Smith”.
Silenzio: lo tengono per una misura circa.
“Riportatemi qui tutti quegli spiccioli”, dice Powerhouse. “Guardate là! Chi sa dirmi il nome di questo posto?”.
“Ballo per bianchi, giorno infrasettimanale, pioggia, Alligator, Mississippi, tanto lontani da casa”.
“Uh-huh”.
Suonano “Sent for You Yesterday and Here You Come Today”.
La cameriera, poggiando il vassoio di birra su un tavolo di neri, si avvicina tesa e apprensiva come una chioccia. “Dicono in cucina, lì dietro, da dove guardano fuori con gli occhi incollati a piccoli buchi , che lei è Mr. Powerhouse”...
“Ci vedono bene stasera, è proprio lui”, dice Little Brother.
“È proprio lei?”.
“Lui in carne ed ossa”, dice Scoot.
“Vuoi toccarlo?”, chiede Valentine. “Mica morde”.
“È qui di passaggio?”.
“Ora hai proprio capito tutto”.
Aspetta come una goccia, rigirandosi le mani.
“Bocconcino, non ce la porti la birra?”.
Gliela porta, e va dietro il registratore di cassa e sorride, voltandosi da varie angolazioni. Il piccolo filetto d'oro nella sua bocca scintilla.
Una volta dice: “Qui passa il fiume Mississippi”.
(... continua)

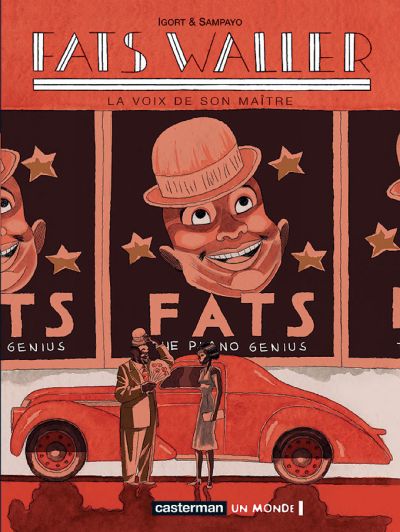


































.png)




