
Quando arrivai a Perugia, nel novembre 1993, c'erano almeno cinque o sei cinema in centro o nelle immediate vicinanze, ai quali si aggiungevano una cineteca e vari cineforum. Io non sono mai stato un grande esperto di cinema, ma in quegli anni ero uno spettatore piuttosto assiduo; diciamo almeno un paio di volte a settimana, alternando roba più mainstream con bizzarrie di vario tipo. Quando, nell'inverno del 1998, cominciai a uscire con quella che sarebbe poi diventata mia moglie, trascinai anche lei - non saprei dire quanto contenta, comunque ci veniva.
Verso la fine degli anni '90 chiuse il Modernissimo, una saletta
d'essai nascosta in un vicolo medievale proprio sopra Porta Pesa. Poco dopo, l'Ariston (due sale di fronte alla stazione) cominciò a proiettare film porno per poi chiudere; adesso al suo posto c'è una sala bingo. Seguì il Lilli, in piazza Partigiani. L'anno scorso hanno chiuso i battenti, non si sa ancora se in via provvisoria o definitiva, il Turreno (due sale, in pieno centro) e il Pavone, cinema-teatro storico, che si affaccia su Corso Vannucci.
Oggi sopravvivono lo Zenith, saletta di dimensioni medio-piccole rintanata in una discesa di Borgo XX Giugno, estrema propaggine del centro storico, e il Sant'Angelo, un teatrino a gestione comunale che ogni tanto proietta film. D'estate, ci sono un paio di rassegne all'aperto. In compenso, negli ultimi dieci anni hanno aperto due mega-multisala da una dozzina di sale ciascuno, entrambi completamente fuori dal centro storico, raggiungibili solo in macchina.
Nel frattempo, io mi sono laureato e ho lasciato il mio appartamentino da studente in Piazza Morlacchi, cuore della Perugia medievale, per trasferirmi sempre più in periferia. Poi abbiamo cominciato a lavorare, sia io sia mia moglie.
Risultato: non si va praticamente più al cinema, perché i due superstiti in centro sono complicati da raggiungere (questioni di parcheggio, soprattutto) e le due multisala proiettano quasi esclusivamente immondizia commerciale. Per un po' abbiamo supplito con VHS e DVD, ma tra il divano di casa e la stanchezza di una giornata in ufficio, il sonno piombava inesorabile.
Negli ultimi due o tre anni, con l'arrivo dei bambini, il lettore DVD è stato monopolizzato dai mostriciattoli, che con feroce ostinazione continuano a richiedere la visione sempre degli stessi cartoni (giuro che ormai sono in grado di recitare a memoria l'intero copione di
Monsters & Co.,
L'era glaciale 1 e 2,
Gli Aristogatti e
Biancaneve e i sette nani). Nelle ore in cui i pargoli dormono, ne approfitto per lavorare.
Insomma, tutta questa tiritera per dire che tra i buoni propositi del 2011 ci ho messo anche quello di ricominciare a vedere un po' di film -
buoni film, intendo, quindi la TV è esclusa
a priori.
Vedremo se riuscirò a mantenerlo. Intanto, questi sono i primi due.
 Gangster Story
Gangster Story (
Bonnie and Clyde) (1967) di Arthur Penn, con Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman, Michael J. Pollard
(DVD, 7 gennaio)
La storia è ben nota.
Texas, primi anni '30. Bonnie Parker, ragazza di buona famiglia annoiata del suo lavoro di cameriera, incontra Clyde Barrow, fascinoso delinquentello di mezza tacca. E' amore a prima vista: Bonnie comincerà a seguire Clyde nelle sue imprese criminali. Quando, durante una rapina, lui uccide un uomo, i due entrano nella lista dei ricercati più pericolosi d'America. Per due anni lasceranno in tutto il Midwest una scia di rapine e di sangue; diventeranno idoli della stampa, che li trasformerà in un misto tra una coppia di amanti diabolici e una versione moderna di Robin Hood; e andranno infine incontro all'inevitabile morte violenta.
Arthur Penn (che, lo ricordo ai più distratti, ha girato robetta come
Anna dei miracoli,
Piccolo grande uomo,
Furia selvaggia,
Alice's Restaurant e si è spento qualche mese fa, a 88 anni) si prende parecchie libertà rispetto ai fatti storici: avvenimenti, nomi, rappresentazione dei personaggi (ad esempio, Bonnie e Clyde erano poco più che ventenni, quindi molto più giovani di come li si vede nel film) e costruisce un film che fa esplodere la tradizione del
gangster-movie.
Violenza esplicita (la celebre, brutale
sparatoria finale) mescolata con toni da commedia, fusione di realismo e lirismo, risvolti psicanalitici (l'impotenza sessuale di Clyde), montaggio sincopato e stile ispirato alla
Nouvelle Vague (la sceneggiatura originale era stata offerta a Truffaut e a Godard).
Anche i protagonisti vengono demitizzati: Bonnie e Clyde sono due ribelli senza causa, due bambini fragili e violenti che giocano a fare i gangster. Ma, soprattutto, tutti i personaggi sono disperatamente soli, sradicati, sullo sfondo di una società senza eroi, in cui i buoni non sono migliori dei cattivi e in cui gli unici lampi di umanità arrivano dai
dropouts, come i tanti contadini rovinati dalla Depressione e trasformati in vagabondi.
Candidato a nove Oscar, ne vinse due e diventò poi uno dei modelli per la
New Hollywood degli anni Settanta. Fra i tanti attori giovani (Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman) fa capolino anche un Gene Wilder al suo esordio cinematografico.
P.S.: tanto per curiosità,
questi sono i veri Bonnie e Clyde e
qui c'è la loro storia.
* * *
 Un condannato a morte è fuggito
Un condannato a morte è fuggito (
Un condamné à mort s'est échappé, ou Le vent souffle où il veut) (1956) di Robert Bresson.
(DVD, 9 gennaio)
Siamo in Francia, durante l'occupazione tedesca. Un membro della Resistenza è condotto in carcere in attesa della fucilazione. Con metodo e caparbietà, progetta ed esegue la propria evasione.
Una trama minimale per un film di assoluto rigore ed essenzialità. La recitazione è ridotta al minimo, i tempi sono dilatati, la sceneggiatura lascia programmaticamente fuori campo tutti gli avvenimenti più drammatici per concentrarsi esclusivamente sui personaggi e sul loro percorso interiore: la determinazione inflessibile del protagonista, il coro dei compagni di prigionia, la progressiva presa di coscienza del compagno di cella.
Anzi, in tutto il film la stessa tematica politica rimane molto sfumata (i tedeschi, ad esempio, compaiono a malapena in qualche scena marginale), dando al film un tono molto più universale, quasi metafisico, sottolineato anche dal sottotitolo francese ("il vento soffia dove vuole").
Un film di un'ora e mezza in cui non succede quasi nulla, in cui persino il finale è svelato già dal titolo, ma in cui la tensione non viene meno neanche per un secondo.
Capolavoro.
 opposto. Quanto Buzzelli si esalta nel bianco e nero, tanto Mattotti lo fa nel colore: i suoi colori accesi, onirici, costruiti con sapienti stratificazioni di pastelli ad olio, su figure nelle quali la stilizzazione più estrema e il realismo più minuzioso si fondono senza soluzione di continuità.
opposto. Quanto Buzzelli si esalta nel bianco e nero, tanto Mattotti lo fa nel colore: i suoi colori accesi, onirici, costruiti con sapienti stratificazioni di pastelli ad olio, su figure nelle quali la stilizzazione più estrema e il realismo più minuzioso si fondono senza soluzione di continuità.

















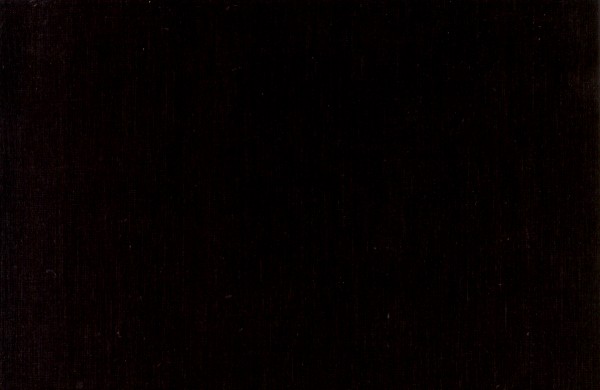



























.png)





