
“Manda un telegramma”, urla all'improvviso Powerhouse nella pioggia, in mezzo alla trada. “Manda una risposta. Com'era quel nome?”.
Cominciano ad essere stanchi.
“Uranus Knockwood”.
“Dovresti saperlo”.
“Ah sì? Ditemi come si scrive”.
Glielo dicono in tutti i modi possibili. Questo li mette di un umore meraviglioso.
“Ecco la risposta. Ce l'ho proprio qui. 'Di che diavolo stai parlando? Non me ne importa un bel niente: Ti ho beccato!'. Firmato: Powerhouse”.
“Questo gli arriverà, Powerhouse?”. Valentine parla con tono materno.
“Sì, sì!”.
Seguendolo in perfetto silenzio, a distanza, lungo la strada buia, come come vecchi fantasmi scuri impregnati di pioggia, i neri hanno paura che muoiano dalle risate.
Powerhouse getta indietro la sua grande testa nella pioggia battente, e un desiderio speranzoso sembra esplodere come un vapore dalle narici dilatate sulla faccia, e diffondere una nebbiolina sui suoi occhi.
“Gli arriverà e lo trapasserà da parte a parte”.
“Proprio così, Powerhouse, proprio così. Devi farglielo sapere”.
Powerhouse emette un sospiro.
“Ma non torni laggiù a fare un'interurbana a Gipsy, come hai fatto ieri sera in quell'altro posto? Ho visto un telefono... Solo per vedere se è a casa?”.
C'è una misura di silenzio. Questo è un batterista pazzo che un giorno o l'altro si farà rompere il collo.
“No”, ringhia Powerhouse. “No! Quante migliaia di volte stanotte dovrò dire No?”.
Tiene alto il braccio nella pioggia.
“Certo che se una sera lascerai uscire tutta la tua voce, poco ci mancherà che arriverai laggiù fino a lei”, dice Little Brother, allarmato.
Se ne vanno lungo la strada, scuotendosi via la pioggia di dosso come uccelli.
Tornati alla sala da ballo, suonano “San” (99). I jitterburg ricominciano, come mulini a vento piantati per terra, e fra le loro orbite – un cerchio, un altro, un lungo affondo e uno zigzag – danza la coppia anziana con antica eleganza, indisturbata e cerimoniosa.
Quando Powerhouse è rientrato dall'intervallo, senz'altro pieno di birra, hanno detto, ha fatto accordare la band alla sua maniera. Non ha schiacciato i tasti del pianoforte per dare il la: ha solo aperto la bocca e ha lanciato delle grida in falsetto – in la, in re, e così via – e loro si sono intonati a lui. Poi si è sistemato al pianoforte, come se lo vedesse per la prima volta in vita sua, e ne ha testato la forza, l'ha colpito giù nei bassi, ha suonato un'ottava con il gomito, ha alzato il coperchio, ci ha guardato dento, e ci si è calato sopra con tutta la sua potenza. Si è seduto e l'ha suonato per qualche minuto con una forza spaventosa e l'ha ridotto in suo potere – un basso profondo e ruvido come una rete da pesca – poi ha prodotto qualcosa di baluginante e di fragile, e ha sorriso. E chi potrebbe mai ricordarsi anche solo una delle cose che dice? Sono commenti ispirati, che gli escono dalla bocca come fumo.
Gli hanno chiesto “Somebody Loves Me”, e lui ha già fatto dodici o quattordici chorus, mettendoli in fila nessuno sa come, e ci sarà da stupirsi se arriverà mai alla fine. Di tanto in tanto lancia un richiamo e grida, “ 'Qualcuno mi ama! Qualcuno mi ama! Mi chiedo chi!' ”.
“Forse...”. Usa tutta la mano destra per un trillo.
“Forse...”. Tira indietro le dita distese, e dà un'occhiata al punto in cui è arrivato. Un grande, impersonale e insieme furioso ghigno gli trasfigura la faccia madida.
“... Forse sei tu!”.
(FINE)



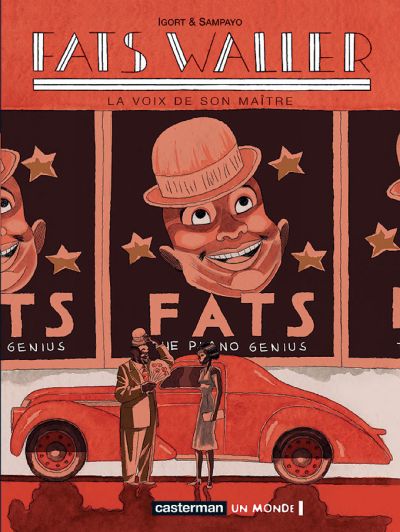


















.png)




