di
Andrea Inglese
Il quadro si presenta stranamente affollato, le figure sembrano
molte, addirittura troppe, tanto che si fa presto a dimenticarle, tutte
quante è impossibile tenerle a mente, e pur enumerandole, con
l’implacabile cadenza matematica, che isola e definisce, anche in tal
caso qualcuna sfugge al conto, si sottrae alla somma finale: quante
persone ci sono, in definitiva, raccolte sulla spiaggia, e sparse
nell’intero paesaggio? Gli agglomerati di persone in primo piano, veri e
propri capannelli, non permettono un conteggio sereno, spuntano sulla
sinistra dei copricapo, bisogna spiare gambe, piedi e calzari, e sulla
destra l’intrusione discreta, parziale, di un viso.
Se
escludiamo la coppia di protagonisti, gli spettatori del dramma – che
in realtà voltano ad esso le spalle – potrebbero essere ventidue, ma
allargando la visuale a colline, promontori, villaggi ancora ben
distinguibili, possiamo aggiungere ventidue ulteriori figure (umane,
antropomorfe), ma senza dubbio ne tralascio alcune, le più remote,
nascoste nelle pieghe della rocca di sinistra, intorno o appena sotto le
due grandi fattorie, mentre è difficile discernere i viventi dalle
statue, nel gruppo di figure che popolano, sulla destra, il villaggio e i
suoi dintorni, soprattutto se, come accade a me, si osserva il dipinto
in un’unica riproduzione, grande quanto una mezza pagina A 4. Non vorrei
occuparmi troppo di questa folla, che si comporta in modo imprevedibile
e disomogeneo, che non sembra appartenere ad un’unica famiglia, e che
comunque, più che come clan o comunità, agisce come moltitudine, animata
da divergenti passioni e interessi: alcuni, stremati dal dolore, non
riescono a mantenersi eretti, piegano le ginocchia, si torcono a terra, e
neppure offrono il volto allo spettatore tanto dev’essere sfigurato e
avvilito; altri invece, con schietta impudicizia, ballano e suonano,
come ignorando qualsiasi calamità, o proprio per sormontare la minaccia e
il ricatto dei lutti a venire, lanciando un esuberante motivo di gioia
attraverso le note di bizzarri strumenti a corda e a fiato, che qualche
musicologo è in grado di riconoscere come emblemi pittorici di arnesi
realmente esistiti, e non capricci di un individuo svagato e talentuoso
nel tratto e nel colore. Basterebbe in realtà dedicarsi a queste figure,
riunite in bande opposte sulla spiaggia, i sofferenti e i gaudenti, gli
stremati e i festeggianti, i malcapitati e gli allegri errabondi,
basterebbe lasciarsi trascinare da questa faida emotiva, che alterna
come una nenia ipnotica tristizia e gioia, lacrime e risa, spasmi
nervosi e passi di danza, basterebbe questo ritmo umano, elementare, per
calmare la mente che vuole invece intessere storie, biografie, episodi,
ruoli. Ma alle spalle del variopinto gruppo dei ventidue, tre decisive
figure campeggiano, anzi quattro, dal momento che una di esse appare
duplicata: si tratta di una donna seminuda, di un mostro ingombrante e
di un guerriero agile e intraprendente. La donna, come in molti sogni
erotici, è legata per le braccia, e offre il suo corpo nudo dai fianchi
al petto: una veste bianca, o un prosaico lenzuolo, la avvolge
accuratamente, coprendole avambracci e gambe. Il suo sesso appare e
scompare, è un suggerimento: la stoffa che le cinge i fianchi si piega
verso il basso, all’altezza del pube, in modo tale che il pensiero,
vorace, vi insista cieco. Ma è la posa, di completo abbandono, con la
testa reclinata sulla spalla destra, gli occhi semichiusi (chi può
dirlo?), i seni spinti in fuori, il busto lievemente piegato verso
terra, è questa condizione di schiava sessuale, ormai arresa alla
giostra di sevizie che l’aguzzino le prepara, è questa spossatezza, che
la rende in qualche modo intollerabile allo sguardo, non davvero mai a
lungo contemplata dallo spettatore, che preferisce spostare l’attenzione
al mostro, il quale campeggia terribile e sconfitto, rovesciato di tre
quarti, al centro del quadro. E su di esso, quasi in punta di piedi, con
discrezione, l’esecutore al lavoro, il giovane killer armato di
sciabola: Perseo.
Di tutte le figure, pur essendo la meno
accomodante, quella del mostro è di certo la più fedele: essa si fa
guardare in continuazione, raccoglie su di sé l’ostinata curiosità dei
vivi, l’indiscrezione degli spettatori, la malagrazia di coloro che
altrove, oltre loro stessi, cercano un approdo: un disgraziato episodio
da rimirare, appena compassionevoli, con la risaputa sete di rivalsa. Il
mostro è lì, perfettamente calato nel suo ruolo di obbrobrio, stolido e
pericoloso, eppure in qualche modo dimesso: volge al suo carnefice la
giugulare, sprofonda su un fianco, si candida ad essere sempre,
consensualmente, ammazzato. Il mostro ha delle strane e fulve barbe, che
tutte vibrano sulla parte posteriore del profilo, mentre dalle narici
schizza filamenti d’acqua e guarda, con presumibile tristezza,
Andromeda: sa che non la vedrà più, che mai l’ha posseduta, che non ha
avuto tempo, a causa dei suoi fitti impegni di rapitore, di concedersi
un attimo di pace con lei. Perseo è discreto e grazioso: uccide con una
disarmante eleganza, tutto piegando il braccio verso di sé, come un
tennista che prepara un rovescio, così che la sciabola rimanga per un
attimo sospesa dietro la sua nuca, prima di calare, secca, sulla gola
del drago acquatico.
(leggi tutto l'articolo su
Nazione Indiana)



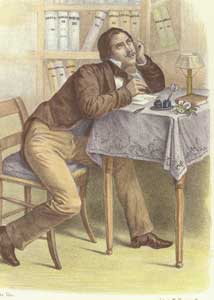









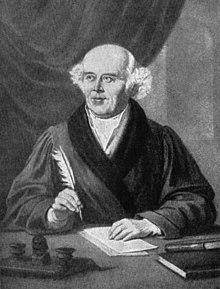























.png)


