
A volte mi chiedo se sia possibile conoscere, non dico una città, ma una strada, un isolato, persino la propria casa o la camera dove si è vissuto per anni e anni.
I luoghi riservano sempre qualche sorpresa. Angoli del mio paese, che credevo di conoscere a memoria, si aprono in scorci inaspettati, persino il panorama dalla finestra della mansarda si offre a volte in una luce nuova, sfuggita a quelle ore di contemplazione oziosa, ipnotica che ci si può permettere solo nell'infanzia e nella prima adolescenza.
La sensazione si fa soverchiante nel caso delle grandi città. Roma, ad esempio, dove persino le pietre corrose dai secoli danno l'impressione di essere altrove: gli infiniti occhi che le hanno intraviste, le mani che le hanno sfiorate, i corpi che le hanno urtate sembrano aver creato una concrezione invisibile ma percepibile, simile al velo di polvere solidificata che maschera il vero colore di un oggetto, ormai sepolto, irrimediabile.
Oppure New York.

Le prime due settimane a New York le passai camminando, su e giù per le strade rettilinee di Midtown, o per quelle più aggrovigliate del Financial District che dopo le cinque del pomeriggio si trasformavano in buie tombe silenziose di cemento verticale, e poi dentro i musei percorsi da stormi di scolari che passavano allegri da un diorama all'altro, o in giro per Central Park con i suoi colori già pronti per la pellicola e i suoi scoiattoli dalle code smisurate, o per le strade di Brooklyn dove lingue volti e colori della pelle cambiavano nel giro di due o tre
blocks e dove ogni tanto si apriva una prospettiva di magazzini dismessi, che sfociava un luccicante fondale di grattacieli, minuscoli oltre l'East River vasto come un oceano. Oppure su e giù per la metropolitana, il cui funzionamento continuò a sfuggirmi, tenace, fino all'ultimo giorno, facendomi ritrovare non so più quante volte in un punto della città che non sapevo più tracciare, in ritardo per l'appuntamento, in una gimcana micidiale di caldo e di freddo (le due manie nazionali degli americani: l'aria condizionata d'estate e il riscaldamento d'inverno, entrambi ferocemente a manetta).
Con il buio, rientravo nello YMCA dove alloggiavo, a Greenpoint, il quartiere polacco di Brooklyn, dopo la cena in un ristorantino che serviva a prezzi modici cibo in porzioni statunitensi (ossia: formato ippopotamo). Il personale consisteva in un cuoco sudamericano ciarliero e pettegolo, una lentigginosa cameriera sedicenne con la bandiera irlandese e una croce celtica tatuate sul braccio e una signora rinsecchita che, come si usa negli States, veniva a riempirmi il bicchiere d'acqua non appena lo vuotavo.
L'ostello aveva un'aria fatiscente ma la camera era linda, un cubicolo confortevole di pochi metri quadrati dove passai la notte più brutta della mia vita, con la febbre a trentanove e tutto l'organismo in rivolta contro il plumbeo cibo americano (per due giorni mangiai solo tè e biscotti, il terzo entrai in una pasticceria e divorai con voluttà orgasmica due fette di torta alla frutta, e passò tutto).
A letto, mi cullava la musica di carburatori e sirene della polizia che è il rumore di fondo di New York, mentre mi passavano davanti agli occhi tutte le immagini della giornata: la finestrella del bagno che dava su un'ondulazione di tetti catramati e, in fondo in fondo, lo sfavillio bronzeo del Chrysler Building; l'uomo dalle braccia ricoperte di pustole scarlatte, accanto al quale nessuno osava sedersi; il giovane ebreo con la barba lunga, lo zuccotto e il caffetano nero che leggeva un libro intitolato “How to Make Your Spouse Happy”; i prati verdissimi e sconfinati del campus della Columbia University; la donna che a Times Square esponeva fotografie di feti smembrati per protestare contro l'aborto; il profilo struggente della ragazza portoricana che sistemava i libri negli scaffali alla City University;

i dodici vertiginosi piani della Bobst Library, simili a un immenso alveare, con i libri tutti a vista in libera consultazione e i ballatoi affacciati sull'altissimo pozzo di luce centrale (chiusi da vetrate, perché pare fosse diventata abitudine dei suicidi servirsene); l'odore di ferro caldo, gomma, polvere e catrame bruciato che domina certi tratti di Broadway e si mescola con i fumi grassi e unti delle bancarelle di cibo a poco prezzo; gli uomini d'affari in giacca e cravatta che mangiavano all'aperto, appollaiati sulle immense scalinate della New York Library; la folla anonima, compatta, che ti proteggeva e non ti faceva mai sentire straniero; i lussuosi condomini dell'Upper East Side, con il tappeto rosso e la tettoia, il portiere in livrea e la
hall ricoperta di specchi e ottone; la stazione della metropolitana di Westchester Square, nel Bronx, decorata con mosaici di Romare Bearden, dove un negro colossale aveva saltato il tornello urlando “fuck your mother” al controllore; Wynton Marsalis acciambellato come un gattone su una poltrona nella sala stampa del nuovo Jazz at Lincoln Center appena inaugurato, con la sua smisurata finestra che occupava un'intera parete e strapiombava sui grattacieli di Columbus Circle; un furgone che si apriva e rivelava uno studio legale su quattro ruote; i gabinetti con le porte che non arrivavano a terra, dalle quali spuntavano file di scarpe multicolori; il tizio identico a Eddie Murphy che riceveva all'ingresso del Jazz Standard, abbigliato come un
pimp anni '40 con una marsina viola e un Borsalino dalla lunga piuma verde; gli attivisti

del Falun Gong impegnati a mimare le torture cui erano sottoposti in Cina; la ragazza che, al tavolo del fast-food, aveva estratto di tasca un fazzoletto, se lo era appoggiato alla bocca ed era scoppiata a piangere in perfetto silenzio, poi lo aveva messo via e aveva ripreso a mangiare; uno spettacolo di marionette contro Bush a Union Square; i commessi che urlavano “next please” non appena il cliente aveva finito di pagare; una panchina con sopra tre gocce di sangue fresco e un preservativo ancora imbustato; la bancarella di libri a Washington Square dove avevo comprato “The Emperor Jones” e l'autobiografia di Armstrong; gli scarafaggi piccoli, sottili, color marrone chiaro, che spuntavano da interstizi invisibili; una scritta sul muro che diceva “it is not an illusion that you can change the world, it is an illusion that you can predict the result”; la città dalla cima dell'Empire State Building, con la crosta appuntita dei grattacieli di Manhattan che all'orizzonte sfumavano nelle case basse del Queen e del Bronx e poi, oltre il fiume Hudson, in una foschia violacea; le oche laccate appese a testa in giù nelle macellerie di Chinatown, con nome e prezzo della merce scritti solo in ideogrammi; il ponte di Brooklyn che si stendeva verso il buio, con gli ultimi raggi del sole a tagliare, quasi orizzontali, i cavi di acciaio, e le macchine che sfrecciavano pochi metri sotto di me.
Ogni tanto mi ricordavo che ero lì per conto dell'università, che avrei dovuto contattare professori, telefonare a centri di ricerca, reperire famiglie italoamericane da intervistare per la mia tesi di dottorato. Ma durava poco: tornavo subito a pensare ai percorsi della giornata, ai frammenti di città raccattati come briciole di Pollicino, e li immaginavo tutti lì in fila, a disegnare la traccia impalpabile del mio passaggio.
Ma se New York apparteneva a qualcuno, apparteneva ai topi.

Erano ovunque, nei condotti delle fogne, nei parchi, tra i cumuli di spazzatura abbandonati sui marciapiedi (a New York non esistono bidoni dell'immondizia), in mezzo ai binari del subway (ratti enormi, neri, pantegane dal pelo ispido e dalla coda simile a una tozza cordicella), oppure li trovavi per strada, dove qualcuno li aveva gettati ancora vivi, invischiati in una trappola appiccicosa, oppure li sentivi squittire al di là di un tramezzo di legno.
L'incontro più ravvicinato lo ebbi negli ultimi giorni della mia permanenza.
Era venuto a trovarmi un gruppo di amici e avevamo prenotato in un alberghetto a poco prezzo nell'Upper West Side, in una traversa fra Central Park West e Amsterdam Avenue. L'albergo (il classico edificio di mattoni rosso cupo, con la facciata zigzagata dalle scale antincendio) si era rivelato peggiore di ogni aspettativa: lo gestivano uno scaltro ragazzo pakistano e una signora incredibilmente obesa, da noi subito ribattezzata “The Blob”, aiutati da un factotum messicano dall'aria losca, che rispondeva al nome di Louie e dormiva in un afoso scantinato puzzolente pieno di lattine di birra, nel quale teneva la radio accesa ventiquattr'ore al giorno.
Appena arrivati, trovammo alla reception due ragazzi francesi imbufaliti, che sventolavano davanti al naso di Blob il cadavere di un sorcetto trovato in camera. La donna emise allora per la prima volta il grido “Louieeee”, che rintronò per i corridoi ed evocò il messicano dal suo scantinato. Quel grido sarebbe diventato il battito di pendola che ritmava le nostre giornate.
In camera, le lenzuola non erano state cambiate e serbavano peli e macchie lasciate dagli inquilini precedenti. Dalle crepe degli infissi potevo vedere la strada (fui costretto a tapparle con carta igienica e nastro adesivo, perché era un inizio di novembre gelido e ventoso) e una notte il mio compagno di camera si svegliò con il termosifone che gli soffiava in piena faccia un getto di vapore rovente. (Chiamammo il messicano, che da quel momento iniziò a odiarci).
Sulla stagnola dei Ritz, lasciati sul comodino la sera prima, avevo trovato piccole incisioni verticali e parallele, che si ripetevano uguali su due o tre biscotti. I denti di un topo avevano scavato quei minuscoli solchi, in silenzio, con metodo e pazienza.
La notte dopo sentii uno scalpiccio, accesi la luce e lo vidi. Era un topino di medie dimensioni, grigio; stava in piedi sulla mia borsa stropicciandosi le zampette anteriori, del tutto simili a mani. Fu una frazione di secondo, poi l'animale schizzò via, si infilò nel ripostiglio e sparì in un buco del muro.
Lo tappammo con giornali bagnati, e il topo non si ripresentò più.


























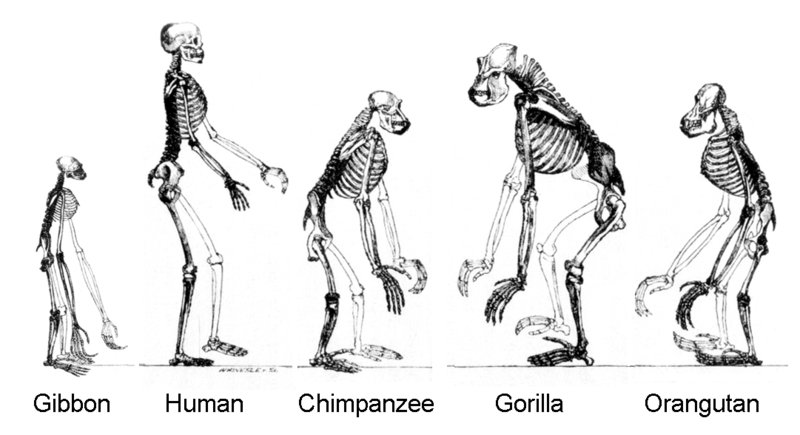






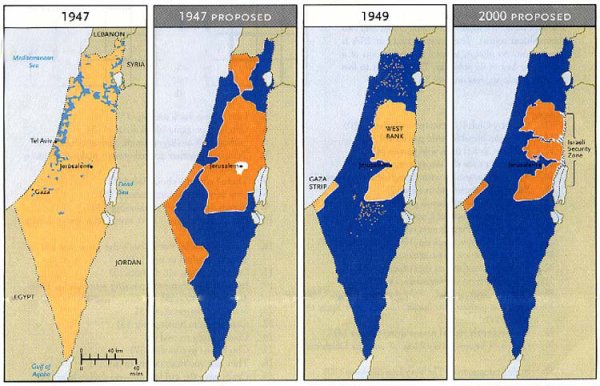



























.png)




