
Antoine batte le unghie sulla lampadina e la fa dondolare; da un graffio sullo smeriglio esce un filo di luce chiara che scivola su e giù per le pareti e si spezza lungo gli angoli dei mobili.
– Era un ragazzo qualsiasi – sospira Fiore lisciandosi i capelli sulla fronte – come me. Poi si sdraia nuovamente e riprende a soffiare in aria delle piume che via vi sfila da un cuscino. – A quest'ora si andava sulla collina a lanciare razzi o a far scoppiare il tritolo nella cava di lignite. Ma già, lui non sa niente di quest'ora.
– No – risponde Antonie, e picchia più forte le unghie sulla lampadina, – e non importa. Mio caro – si avvicina al ragazzo fino a toccarlo con il volto – e neanche a lui, ora importa. Lascia stare, succede sempre così; si va e si viene e non facciamo in tempo neppure a guardarci attorno. Un giorno anche tu non sarai più niente e anch'io, prima di te. Vuoi dell'altro bodino?
Il ragazzo non gli risponde ed egli si alza dal divano e va a chiudere le imposte, marcie e piene di fessure; prima di chiudersi sbattono sui fili di ferro per la biancheria e stridono a lungo nel solco del davanzale. – Tuttavia dimenticare – soggiunge Antoine – non è così facile come sembra, ci vuole del tempo. Anche se si è morti.
Ora che le imposte sono chiuse la camera sembra più buia; ad eccezione di quel filo che oscilla, la luce rossocupa della lampadina non illumina nulla in modo particolare; si disperde nella stanza come un riflesso rilevando soltanto lo specchio, gli oggetti di vetro, gli occhi, e le scarpe di Antoine.
– Con questa luce non ci si vede.
– Non ci si vedeva neanche prima, sono le sei.
– A lui non importerà niente di quest'ora?
– Mah, può darsi che se ne sia già dimenticato, – sussurra Antoine e, immerso il dito nel bodino lo succhia rumorosamente.
– Credi in Dio tu? – continua con il dito in bocca.
– Ci ho sempre creduto, se vuol dire l'Inferno, il Paradiso e il Purgatorio.
– Ah, sì?
– Certo, e ci penso sempre anche. Penso a Dio, alle anime del Purgatorio; una volta mia nonna mi faceva dire il requiem aeternam; ma ora l'ho dimenticato. Sarebbero inutili perché, tanto, i morti riposano in pace lo stesso.
– Lui non credeva in Dio, – dice Antonie. Ferma la lampada, per favore, appena la tocchi va avanti e indietro e non la finisce mai.
Fiore la prende in mano e chiude un occhio per guardare dentro lo spiraglio; ma subito dopo chiude anche l'altro perché l'intensità del filo luminoso lo fa lacrimare.
– Hai ragione a non dirle più – riprende Antoine – non potrebbero ascoltarti là dove sono; hanno altro da fare.
– Cos'hanno da fare? Sono morti.
– Non sono morti del tutto, mio caro; prima devono marcire, devono andare via dalla terra, il più presto possibile, andarsene, buttar via tutto. Credimi, non è mica facile dimenticare; noi li dimentichiamo, ma loro, poveretti, restano anche oltre il nostro ricordo. La terra serve, poco; sai, ci vogliono anni per marcire, per buttar via questa bella polpa cicciosa, e poi ci sono le ossa, dure come pietre, che si sciolgono un poco, un poco alla volta, queste puttane: dopo dieci anni si spellano un pochino; dopo altri dieci, se la terra è buona e l'acqua vien giù a diluvi, allora cominciano a marcire, ma poco, soltanto alla superficie. Così passa il tempo e loro stanno là fermi senza muovere un dito, rabbiosi e cattivi come cani, ad aspettare i temporali per fare più presto. Poi, eh! Poi c'è la cosa più brutta di tutte.
– Cos'è? – chiede Fiore debolmente; e gli sembra di avere ancora negli occhi quel filo luminoso che a tratti si spegne e gli chiude le pupille nel buio.
– Il ricordo di tutto quello che avevano addosso, mio caro; occhi, capelli, braccia, sentimenti, cose viste, tutto, per dispetto si riunisce e li fa vivere ancora; vanno in giro per la città, per le case e vengono a salutarci. Ma loro non sanno niente, hai detto giusto tu, sono morti, non sanno niente, stanno fermi immobili dove li hanno messi; in qualunque posto, sotto terra o sopra la terra, o ingorgati dentro una fogna, per loro, va tutto bene. Non mangiano più come noi; ma non hanno finito di pensare. Nessuno sa cosa sono, mio caro, e forse non sono niente. – Si china a succhiargli le labbra.
– Era il mio migliore amico – sussurra Fiore dopo una pausa, e allunga una mano a raccogliere una piuma.
– Già, a te importa solo lui, non hai altri a cui pensare. A te importano la sua voce, la sua figura; ti aspetti che a quest'ora, come al solito, lui si faccia vedere a quella porta, tutto nero e con quel suo sorrisetto; che venga avanti con le mani in tasca e si sieda qui a scaricare lo stomaco. Capitava anche a me una volta, quando la gente moriva sotto i baldacchini e a tutti dispiaceva; ma adesso, mio caro, la gente muore con le unghie sporche e il cappello che cade da un lato; e lascia perdere l'agonia, il segno della croce e anche chiamare aiuto.
Antoine parla lentamente, e a ogni parola getta per terra una pallina di vetro colorato che stride sulle piastrelle e corre ticchettando fin sotto l'armadio.
– Alla mattina presto i gelatai o un contadino che vende erba melissa trovano uno seduto nei pisciatori con le gambe larghe e i pantaloni sbottonati che invece di essere ubriaco è senza il cuore. Oppure, all'ospedale, una monaca passa davanti al letto di una donna e vede che quella non si muove più; due ore fa continuava a lagnarsi e lei allora le aveva dato un uovo che ora vien fuori dalla bocca e dal naso; allora pensa: «Un uovo portato via dalle mani della Divina Provvidenza». E se tu muori, tua madre, che ha più soldi di quella di lui, dopo le lacrime penserà al carrozzone di lusso e a una bella corona di fiori bianchi. – Infila la mano in un sacchettino di broccato. – Per tutti, quanti siamo, un giorno o l'altro c'è la fine; dicono che sia stato Dio, ragazzo, quando era al mondo, ad avere per noi questo pensiero gentile. Fiore caro, c'è poca speranza che il tuo amico faccia la strada fin qui. Sarebbe bello, lo so; ma non arriverà a tanto; e tu dovresti pensare piuttosto a te stesso, – soggiunge stirandosi le labbra in un sorriso.
Il ragazzo si liscia ancora una volta i capelli e la piuma gli sfugge dalla mano; poi si alza e va a scostare la tenda che copre l'uscio.
– Veniva di qui – dice con la faccia protesa nell'andito buio e le lacrime gli cadono sul petto, sconsolatamente. – In fondo, che cos'ha fatto, Dio, per lui?



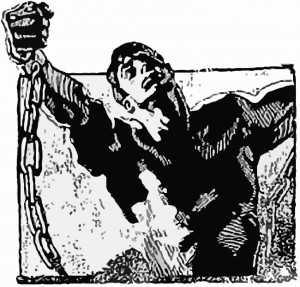





















.png)



